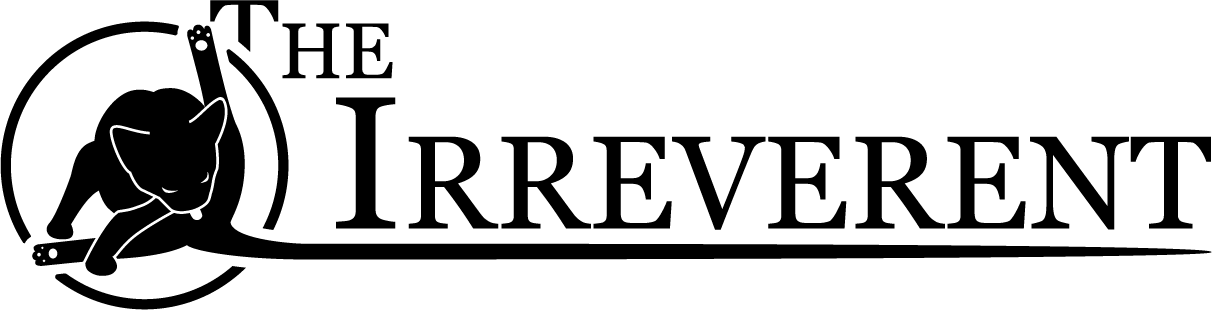Allostorico dramma sulla reificazione della persona che colpisce e inquieta, ma si adagia in un malinconico fatalismo.
Inesorabile e cupa rappresentazione del destino, dell’amore e della perdita, emotivamente stentata, priva di tensione e superficiale, che si perde nella sua stessa malinconia. Mark Romanek (One hour photo) porta in scena la vicenda raccontata nell’omonimo romanzo di Kazuo Ishiguro, conferendo a questo slow-burn drama una patina di lirica nostalgia in cui l’accettazione e la speranza prevalgono su qualsiasi tentativo di ribellione.
Ciò che inquieta è certamente la visione spaventosa di un prossimo futuro – reso tangibile dal trattarlo come recente passato – in cui la norma sociale prevede la creazione della vita allo scopo di produrre parti di ricambio. Queste nuove entità non vengono percepite nel loro insieme di persone, ma unicamente come somma di organi da espiantare. La naturalità con cui il potere, socialmente stabilito, viene esercitato dalle istituzioni educative su questi bambini, oppressi e senza futuro, sconvolge.
Tuttavia l’incapacità dei protagonisti di mettere in discussione il proprio destino risulta in un letargo emotivo più che un sentimento represso. A dispetto di uno stile visivo semplice ed elegante, si avverte la mancanza di una tensione drammatica che rende difficile connettersi ai personaggi e all’angoscia della loro situazione. Never let me go non coinvolge.
Nemmeno la notevole performance di Cary Mulligan, Keira Knightly e Andrew Garfield aiuta nel processo di identificazione con l’agghiacciante rappresentazione di questa crudele realtà alternativa. Complice una sceneggiatura piatta e non all’altezza che decide di lasciare sullo sfondo alcune spinose questioni morali, rivestendo tutto con un velo di fatalismo. Una storia fragile, come i suoi protagonisti, debolmente poetica che attende passiva il compimento del suo piatto, distaccato e freddo destino.